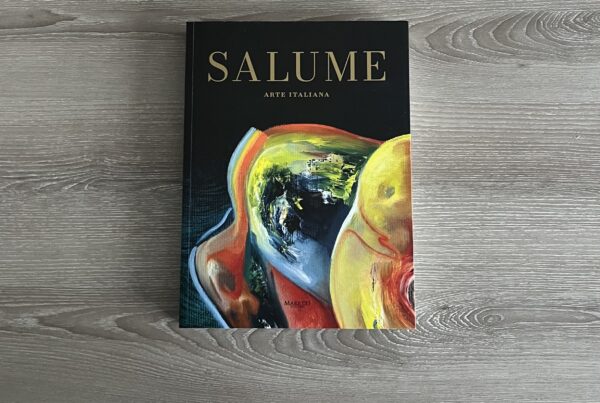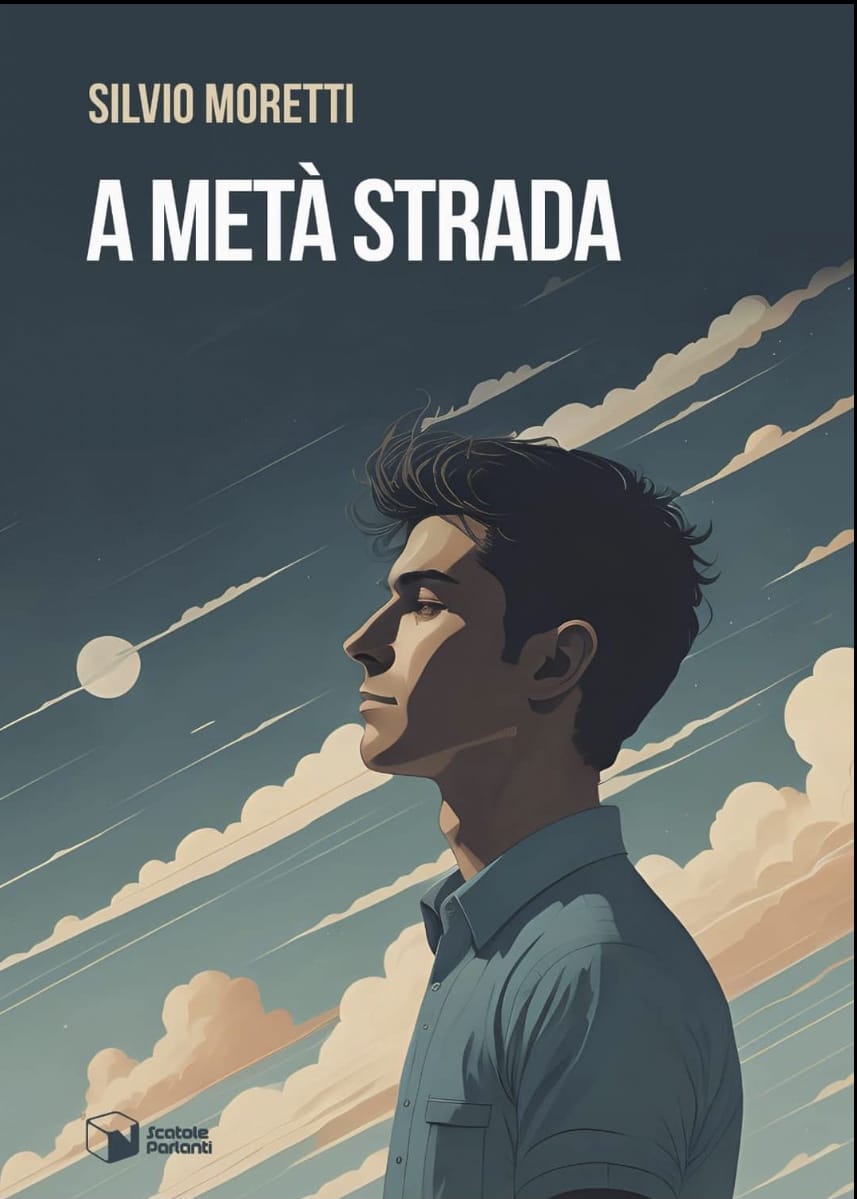«Le idee fanno paura a chi non ne ha». Vasco Pratolini
Purtroppo ci ha lasciato dopo una lunga malattia. Oltre ad essere un amico con cui ho fatto un lungo tratto di strada insieme Sandro Antoniazzi è stato per trent’anni sindacalista: segretario della Fim-Cisl di Milano, segretario generale della Cisl di Milano, poi segretario generale della Cisl Lombardia. Membro della Commissione «Iustitia et Pax» della diocesi di Milano e dei consigli d’amministrazione della Banca Popolare di Milano, della Banca Popolare Etica, della Fondazione Lombarda Antiusura.
Condivido volentieri la recensione di Francesco Lauria del suo ultimo libro, pubblicata sul Diario del Lavoro…
Gli occhi di Sandro Antoniazzi, già mitico segretario della Fim e della Cisl di Milano e della Cisl della Lombardia, sono da sempre accesi, vivaci. Il suo sguardo non si è mai fermato, fin da quando accettò, nel 1992, in un momento difficilissimo per la società e la democrazia italiana, di uscire dall’impegno diretto nel sindacato per sostituire l’indagato Mario Chiesa, alla guida del Pio Albergo Trivulzio. Occorreva allora una persona di specchiata e riconosciuta onestà e nessuno, meglio di Sandro, la poteva rappresentare, testimoniare. Innumerevoli sono le opere, ma anche i libri di Sandro, su tantissimi temi, con una prevalenza all’attenzione all’evolvere del sindacato e all’etica del sindacalismo.
Il suo ultimo libro: “Combattere la bella battaglia. Il sindacato come soggetto di trasformazione della società”, pubblicato dalla casa editrice della sua Cisl, Edizioni Lavoro, è stupendo, da leggere tutto d’uno fiato, pur se diviso in due parti: una di testimonianza della sua “storia sindacale”, iniziata all’Ufficio Studi della Cisl di Milano nel lontano 1958, l’altra tutta di prospettiva sull’evoluzione, anche mondiale, dell’associazione e del movimento dei lavoratori, come lui definisce molteplicemente il sindacato.
La sua d’altronde è, da sempre, una storia, una vita rivolta al futuro, curiosa e colta, ma immersa nell’impegno quotidiano proteso al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e delle persone in generale. Nel libro si pone un interrogativo cruciale, anche a partire dalla sua esperienza diretta: “è in grado, il sindacato, di affrontare i grandi temi della nostra epoca, di indicare una prospettiva convincente per il futuro?” Nel suo testo, fin dalla dedica iniziale, il sindacalista milanese rivendica la sua appartenenza, identità “carnitiana”.
“In ogni situazione – afferma Sandro – l’idea di Carniti e del suo gruppo era di forzare le condizioni sociali del tempo per realizzare un avanzamento dei rapporti economico-sociali relativi ai lavoratori”. Così Antoniazzi, affronta nel suo volume la passata natura operaia del sindacato, i temi dell’oppressione e dello sfruttamento, l’origine delle lotte unitarie alla fine degli anni Cinquanta, l’esemplarità della Fim di Milano. Sì, quella di Pierre Carniti, un sindacato: “aperto al mondo e alla cultura”. Interessante è il suo racconto del culmine delle lotte operaie, dell’incontro, non sempre facile, con il movimento degli studenti, dei tre grandi obiettivi del sindacato a cavallo degli anni Sessanta e Settanta: una contrattazione aziendale avanzata, la battaglia per l’unità sindacale, la lotta per le riforme.
Forse, ancora più da leggere, è il capitolo sul “lungo ripiegamento sindacale”, lucido, pieno di argomentazioni, del tutto privo di nostalgia, con il racconto della fine dell’unità e degli esiti complessi dello scontro sulla scala mobile. Tutta da analizzare, meditare e diffondere la parte sul sindacato nel futuro che si sviluppa sui seguenti assi: l’economia mondiale, l’Europa e i suoi problemi, la debolezza dell’Italia, la necessità di un sindacato forte e ambizioso, la dignità del lavoro e del lavoratore, la formazione e la cultura, il rapporto lavoro-vita, la partecipazione e i problemi sociali.
Segue un capitolo più tecnico sulla costruzione di nuove prospettive: dal ruolo diretto del sindacato nella formazione professionale e nelle politiche attive del lavoro, alla questione importantissima della dimensione relazionale nel lavoro di oggi, ai rapporti con il terzo settore e il volontariato, alla questione della valorizzazione dell’associazionismo e di un rinnovato mutualismo, sino all’emancipazione guidata dalle parti più deboli della società (le donne, gli immigrati, i lavoratori poveri).
Il libro si conclude con un capitolo significativamente intitolato: “un lavoro libero in una società giusta”.
Qui Antoniazzi rivendica il perdurante carattere fondamentale del lavoro, la centralità di una logica partecipativa, anche in sintonia con l’iniziativa legislativa promossa dalla Cisl (ora alla prova decisiva della reale implementazione sui luoghi di lavoro), il rapporto diretto tra: “lavoro libero e società giusta”. Conclude il capitolo un approfondimento tutto dedicato ai cambiamenti necessari al sindacato. “Il sindacato – scrive l’ex guida della Cisl di Milano – deve avere una propria identità, che costituisce il suo riferimento ideale condiviso, ma deve poi aprirsi il più possibile, se vuole essere in grado di cogliere il nuovo. Non è un’organizzazione autosufficiente: opera in una realtà vasta e molteplice, dove incontra molte altre forze, con alcune delle quali deve necessariamente collaborare, e con cui si possono condividere idee e obiettivi (associazioni ambientaliste, cooperative, associazioni femministe, terzo settore, ecc.)
Il sindacato – continua Antoniazzi – ha bisogno per questo di solidi rapporti con gli intellettuali, al fine di non avere difficoltà a muoversi nella dimensione culturale, che offre infinite possibilità di crescere”. Per l’ex sindacalista, inoltre, non basta cambiare le politiche, occorre ancora di più cambiare le strutture.
Antoniazzi non finisce di riservare sorprese al lettore: il libro si arricchisce di un’interessantissima appendice, dedicata al “sindacato, la Cisl e le radici cristiane”, tema già affrontato dall’autore in diversi altri volumi. Se i primi due paragrafi sono riservati al “lavoro e la Chiesa di ieri” e al rapporto tra fede, laicità e vita sociale, particolarmente importanti sono le riflessioni successive dedicate al pensiero della Cisl delle origini e alla sua innegabile (anche se talvolta inopinatamente negata) evoluzione nel tempo.
Il libro si conclude con due riflessioni: la prima sul rapporto tra cristianesimo e organizzazione dei lavoratori che impegna direttamente e intimamente la figura del sindacalista credente, la seconda sui: “valori ideali del sindacato”, a partire dalla dimensione planetaria delle lotte dei lavoratori e delle lavoratrici, nell’impegno ad unire un mondo del lavoro frammentato, nel regolare e organizzare nuove sfide come la questione: “lavoro-vita”.
La questione del rapporto tra tempi di lavoro e tempi di vita è stata mirabilmente approfondita dall’ex sindacalista lombardo nel suo precedente e sorprendente libro, curato insieme alla femminista Paola Melchiori: “Cura e democrazia. Il valore politico della cura” (Castelvecchi, Roma, 2023).
Termina significativamente così il suo ultimo volume Antoniazzi: “la Cisl e Romani parlavano di ruolo dirigente del sindacato, ritenendo tale ruolo essenziale per una società che crescesse in modo giusto: ci troviamo di fronte allo stesso impegno, sapendo che oggi il compito è più difficile e che la fedeltà a questo principio non consiste nel ripetere le formule dell’origine, ma nella capacità autonoma di individuare nuove soluzioni a nuovi problemi”. Gli occhi e lo sguardo di Sandro Antoniazzi ci accompagnano, come sempre e per sempre, nel futuro.
Un futuro di impegno, sapienza e Speranza, in cui, come ha scritto l’evangelista Luca, è importante sempre chiedersi, come sempre ha fatto Sandro, senza mai tirarsi indietro: “Chi è il mio prossimo?”.