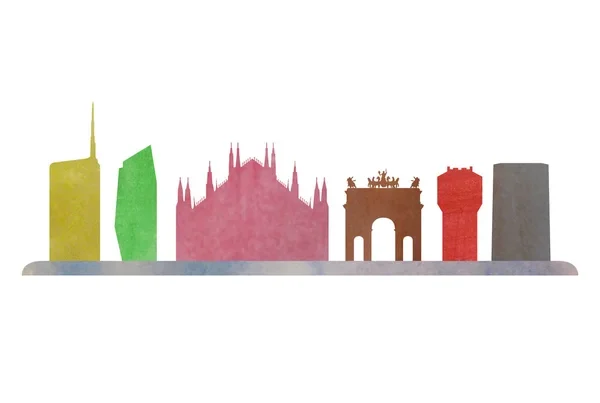All’inizio di questa incredibile storia c’era una semplice bottega. Al suo interno due figure che si sono conservate per lungo tempo praticamente sempre uguali a sé stesse. Il bottegaio e il garzone di bottega. Gli acquisti e le vendite erano gestite dal primo. I lavori di fatica e la consegna a domicilio dal secondo. Veniva pagato in nero e integrava con le mance. Spesso era minorenne. Nel tempo è poi comparsa, alla cassa, la moglie del proprietario. Questo modello ha retto per secoli. La prima vera rottura del modello avviene nella seconda metà del XIX secolo quando nascono i Grandi magazzini. Le Bon Marché nel 1852, a Parigi è considerato il primo grande magazzino moderno. Con la Rivoluzione Industriale, aumentano produzione e salari. Si forma così un nuovo ceto medio con maggiore potere d’acquisto.
Il secondo balzo in avanti arrivò nel 1917 quando l’Ufficio Brevetti degli Stati Uniti assegnò a Clarence Saunders un brevetto per un self-serving store. Saunders autorizzò l’uso di questa metodologia commerciale ad altri negozi di alimentari indipendenti che presero il nome di Piggly Wiggly. Cinquant’anni dopo il terzo balzo con la nascita dei centri commerciali. Il Southdale Center a Minneapolis, progettato dall’architetto Victor Gruen fu il primo. Curiosamente questi spazi, erano inizialmente concepiti come luoghi di aggregazione sociale e non solo come luoghi di acquisto. Il quarto balzo è l’apparire sulla scena dei category killer. Concetto nato e sviluppato principalmente negli Stati Uniti durante gli anni ’80 e ’90, con la proliferazione di negozi come Toys R Us (giocattoli), Home Depot (fai da te), Best Buy (elettronica) e Bed Bath & Beyond (articoli per la casa), che hanno trasformato il modo con cui le persone acquistavano questi tipi di beni. Il quinto balzo avviene con la nascita delle vendite online, o e-commerce. Siamo negli anni ’70 con l’introduzione dell’EDI (Electronic Data Interchange), che permetteva alle aziende di scambiarsi documenti elettronicamente. Tuttavia, lo sviluppo più significativo si ebbe negli anni ’90 con la nascita dei primi siti web di e-commerce. Un momento chiave fu nel 1994, quando Phil Brandenberger fece il primo acquisto online con carta di credito, acquistando un compact disc di Sting secondo Doxee. Nel 1995 Jeff Besoz lancia Amazon (leggi qui). Negli anni 2000 la sua diffusione è favorita dalla crescita dell’ADSL e dalla regolamentazione degli standard di sicurezza. Dopo il 2010 il commercio elettronico diventa una componente fondamentale dell’economia. Oggi, l’e-commerce è un fenomeno globale, con milioni di persone che acquistano online ogni giorno, anche tramite dispositivi mobili.
Sul piano del lavoro, il garzone di bottega ha dovuto però aspettare la fine del 1800, con la costituzione delle Società di mutuo soccorso e delle Unioni di miglioramento, per vedere formalizzate le prime norme contrattuali del settore commerciale. Nel 1919, in Italia, il primo decreto nazionale sul contratto di lavoro. Sono così migliorate le condizioni dell’ambiente di lavoro, riducendo l’orario di lavoro, introducendo il riposo festivo settimanale, l’assistenza in caso di malattia e i congedi annuali retribuiti e dando così più dignità ai lavoratori. Tutto questo è alle spalle. Per alcuni la rivoluzione prossima ventura, quella caratterizzata dall’intelligenza artificiale ci porterà a un retail molto più personalizzato, lato cliente. La tecnologia segnerà una nuova era, l’essere umano farà la differenza. L’evoluzione dell’AI nel settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) sta aprendo nuove frontiere di efficienza, personalizzazione e innovazione: ridefinendo le esperienze d’acquisto e ottimizzando le operazioni interne, l’AI sta diventando un pilastro fondamentale per le strategie di crescita e di servizio al cliente. L’AI permette di analizzare comportamenti e preferenze di acquisto, offrendo raccomandazioni personalizzate che migliorano significativamente l’esperienza sia online che offline. Inoltre, l’automazione dei processi logistici e la gestione dell’inventario tramite AI portano a una riduzione dei costi e a un’efficienza operativa migliorata, con sistemi che possono prevedere in modo autonomo i livelli di stock ideali e gestire in tempo reale gli ordini di ri-approvvigionamento.
Siamo però di fronte a un grande paradosso. Gli algoritmi e l’IA faranno parte del lavoro, ma, per tutti, la relazione e quindi il servizio sarà il grande elemento di differenziazione. Il garzone di bottega riacquisterà quindi una sua centralità? I numeri in gioco, a mio parere, invitano alla cautela. Certo la qualità del servizio e la relazione con il cliente impongono una percentuale di lavoro altamente formata e specializzata. Ma tutto questo continuerà a necessitare, alle spalle, una quantità enorme di lavoro povero. Fuori e dentro i tradizionali luoghi di lavoro. Lavoro invisibile che garantisce una transizione di attività che, in sé, continuano ad essere in perdita e lo saranno fino a quando l’intero puzzle si ricomporrà. Se mai si ricomporrà.
Alcuni segnali sono già evidenti laddove la tecnologia spinta, segnala un confine. I riders, gli addetti nei magazzini della logistica, gli autisti consegnatari, le guardianie, i subappalti compresa una larga fascia di addetti della GDO di fatto obbligati al part time involontario. Questo e altri invisibili costituiranno la spina dorsale del lavoro povero dei prossimi anni. Almeno fino a quando non verranno resi obsoleti dalla tecnologia se i costi lo consentiranno. In futuro, tra robot nei magazzini, furgoni appositamente equipaggiati con tecnologia per supportare il trasporto e la consegna di generi alimentari, casse automatiche e i sistemi automatizzati per l’evasione degli ordini di generi alimentari online, dovrebbero completare questa transizione. Il problema sul piano occupazionale sarà la sua durata. E se, nel frattempo, prepareremo queste persone al cambiamento o le lasceremo al loro destino. C’è chi ipotizza dai cinque ai dieci anni. Nonostante le evidenze suggeriscano che l’AI tenda più a creare nuove opportunità di lavoro che a eliminarle (leggi qui), la paura che possa sostituire il lavoro umano è un’altra questione critica; soprattutto per chi attraversa per età, istruzione e contesto sociale questa transizione.
Questa sfida richiede un approccio olistico all’adozione dell’AI, che dovrebbe comprendere un management preparato e coinvolto, risorse economiche adeguate, politiche di governance dei dati, formazione continua per i dipendenti e una chiara comunicazione dei benefici dell’AI indispensabile per superare le resistenze interne alle imprese. Nell’economia agentica, la sfida non è solo tecnologica. È organizzativa, culturale, etica. Prepararsi a questi cambiamenti è quindi fondamentale.